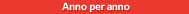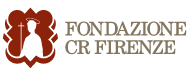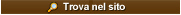Immagine di copertina:
Immagine di copertina:Fabio Borbottoni, Il carcere delle Stinche a Firenze, 1860 circa. Collezione Cassa di Risparmio di Firenze
di Francesco Mineccia (Università del Salento)
[Le parole evidenziate nel testo rinviano a link esterni elencati in fondo alla pagina]
Nel secolo XVIII il tumulto costituiva in tutta Europa una delle espressioni più tipiche del malcontento popolare. La Toscana del tempo non faceva certo eccezione a questa prassi.

Fig. 1. Guardiolo sedentario di pulizia in tempo di notte, da F. Pieraccini, Collection des costumes des divèrses Provinces du Grand Duché de Toscane, Paris, 1826; ristampa anastatica: Firenze, Ediz. bancarie Cassa di Risparmio, 1976
Gli episodi di protesta popolare, che hanno costellato fittamente tutto il granducato di Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena (1765-1790), furono originati, in gran parte, dall’intensa opera riformatrice avviata dal giovane principe. La soppressione e la ristrutturazione di uffici e magistrature al fine di snellire e rendere più efficiente l’apparato burocratico provocò un gran numero di scontenti tra coloro che venivano a perdere di punto in bianco privilegi consolidati o addirittura il posto di lavoro. Il ribaltamento del rapporto città-campagna e di quello città dominante-provincia, inserito nel più ampio programma di razionalizzazione e unificazione amministrativa dello Stato, anche in questo caso, andava a colpire secolari privilegi e contemporaneamente privava le plebi urbane di quella protezione loro garantita dal vecchio sistema vincolistico e annonario. Infine, l’opera di moralizzazione della vita pubblica finiva per ostruire quei numerosi canali che in passato erano serviti a stemperare o a scaricare le tensioni accumulate, soprattutto tra il «basso popolo»: in particolare l’abolizione delle feste religiose e la lotta alla superstizione, la riduzione di taverne e osterie, la proibizione di feste e balli in maschera, del gioco delle carte e dei dadi, il maggior controllo e progressiva abolizione della prostituzione, e via dicendo.
In questo contesto, venne via via inserendosi un nuovo fattore dirompente: la conflittualità tra l’esercito e l’apparato poliziesco del Granducato, tra le due forze cioè preposte al mantenimento dell’ordine interno ed esterno del Paese. L’odio verso i militari si aggiungeva a quello più generale della popolazione verso gli esecutori di giustizia, odiati e disprezzati per la natura stessa del loro mestiere, considerato infamante e per i metodi decisamente brutali con i quali amministravano la ‘giustizia’. Le denunce di abusi di ogni genere, «mangerie», violenze, sopraffazioni, erano all’ordine del giorno in tutto il Granducato, nelle città come nelle campagne.
Le origini e le motivazioni dell’accesa ed aspra ostilità tra «sbirri» e militari (che sarebbe culminata nei gravi fatti di Firenze, Siena e Arezzo, rispettivamente nel 1774, 1779 e 1782) è da individuare soprattutto nella riorganizzazione della polizia, avviata dal 1774, con l’intenzione di farne uno strumento più efficiente e più adeguato ai bisogni del nuovo Stato, e nel contempo di renderla meno invisa alla popolazione. Allo stesso modo si era cercato di adeguare l’esercito alle necessità di uno Stato praticamente senza nemici esterni, riformandolo varie volte tra il 1777 e il 1787. Il fatto è che le riforme, più che a una modifica sostanziale dei sistemi sui quali si fondavano entrambi gli organismi, tesero ad una semplice riorganizzazione e, nel caso dell’esercito, ad un ridimensionamento dell’esistente con il risultato di accentuare le tensioni all’interno dei due corpi armati e di acuire la loro reciproca insofferenza e rivalità. Così, ad esempio, il piano di trasformare l’esercito in una milizia civica per impieghi esclusivamente interni non poteva certo dare i frutti sperati, essendosi mantenuto il vecchio sistema di arruolamento forzato dei soggetti ritenuti più pericolosi (discolato), senza considerare la confusione di ruoli che inevitabilmente veniva a crearsi con la polizia. Allo stesso modo non era pensabile di poter levare «l’infamia agli esecutori» se poi si continuava come in passato ad assumere per questo importante e delicato compito soggetti poco raccomandabili e non di rado veri e propri delinquenti.
L’episodio più grave e più sanguinoso di questo aspro contrasto tra militari e sbirri, per il numero di persone coinvolte, per l’estrema violenza che lo caratterizzò, per il massiccio intervento repressivo che fu necessario per sedarlo, si verificò proprio nella capitale nel maggio 1774. Un voluminoso dossier conservato nel fondo Segreteria di Gabinetto dell’Archivio di Stato di Firenze consente un’analisi di questa vicenda meno legata alle versioni ufficiali, trattandosi di documenti (memorie, relazioni, atti processuali e in particolare una Istoria del fatto seguito nella sera del di 9 maggio 1774 fra la soldatesca ed i famigli, e dell’esempio dato per tal motivo al pubblico) prodotti per esclusivo uso interno, non destinati cioè ad essere conosciuti dal pubblico.
La scintilla che diede fuoco alle polveri fu, quasi certamente, l’ordinanza che autorizzava gli esecutori a fermare tutti i militari trovati per strada, nelle osterie o in altri locali pubblici «dopo la chiama» della sera, e di condurli in stato di arresto e disarmati «alla Gran Guardia», cioè al palazzo del Bargello. La sera dell’8 maggio un gruppo di granatieri, già in fermento per via dell’ordinanza di cui si è detto e per gli scontri precedenti mai dimenticati, sorpresero e assalirono un famiglio della Congregazione dei poveri tentando di ucciderlo a sciabolate. Ne nacque un violento tafferuglio per sedare il quale fu inviata, su richiesta del bargello, una «aspezzata» di fucilieri. Questi, pur avendo preso le parti dei loro colleghi, scortarono il famiglio sano e salvo al palazzo degli Otto di guardia. Nelle ore seguenti, tuttavia, si erano moltiplicati i segnali di una tensione ormai sopra i livelli di guardia: il palazzo del Bargello era praticamente circondato da gruppi di militari in atteggiamento minaccioso. La mattina del 9 maggio, dopo le avvisaglie della sera precedente e malgrado l’ordine del granduca di tenere i soldati consegnati nelle fortezze, un gran numero di militari tornò a circondare il palazzo, dove si erano ritirati e barricati 120 sbirri armati fino ai denti. Il via agli incidenti della giornata lo dette uno dei famigli di guardia al palazzo, il quale sparò ad alcuni granatieri, ferendone gravemente due. A quel punto i granatieri si gettarono all’assalto del palazzo pretorio all’arma bianca. Il primo dei militari che riuscì a raggiungere il portone fu freddato da un famiglio che continuò a far fuoco ferendo anche un popolano. Questo nuovo fatto di sangue eccitò ancor di più gli animi e lo scontro tra militari e famigli si allargò rapidamente, con l’intervento di un gran numero di popolani. La ‘bassa plebe’ poteva dar così libero sfogo al proprio odio contro gli sbirri. Numerosi popolani, accerchiato il palazzo del Bargello, incitavano i soldati «a sfondare la porta per andar a trucidarli tutti».

Fig. 3. Reggimento Dragoni di Toscana, da B. Mugnai, Soldati e milizie toscane del Settecento, Roma, Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, 2011
Una compagnia di fucilieri inviata sul posto per sedare il tumulto era subito passata dalla parte dei rivoltosi ed aveva aperto il fuoco contro porte e finestre del palazzo. Uno dei granatieri, certo Michele Giannetti, definito poi negli atti processuali uno dei capi del complotto, sparò contro la finestra dove si trovava appostato il bargello, indicatagli da un garzone di fornaio, certo Gaetano Lapucci anch’esso qualificato poi come «capo popolo». Il bargello, capitano Chelotti, che da una finestra stava osservando il tumulto, ebbe appena il tempo di ritirarsi.
Il tumulto crebbe ancora di intensità e per oltre due ore la confusione fu indescrivibile. Pietro Leopoldo, subito avvertito di ciò che stava accadendo, aveva disposto l’immediato invio di un distaccamento della sua guardia personale per sedare la sommossa e, nel contempo, il rientro in città dal Poggio Imperiale, dove si trovava in villeggiatura. Riportato così, sia pure a fatica, l’ordine, la situazione sembrava ormai sotto controllo al punto che il granduca decise di fare ritorno al Poggio Imperiale. Le misure prese dalle autorità si rivelarono però insufficienti a calmare gli animi. La mattina del 10 maggio, infatti, attorno al palazzo degli Otto si era di nuovo radunata una folta «truppa di birbanti» con atteggiamento aggressivo. Stavolta però, non essendo presenti i soldati armati come il giorno prima, non vi furono difficoltà nel procedere all’arresto dei più facinorosi.
Nel corso delle due giornate furono arrestate oltre ottanta persone tra militari, famigli e popolani. I giorni successivi, pur senza le violenze dei precedenti, rimasero carichi di tensione. Per mantenere l’ordine Pietro Leopoldo si vide costretto a far affluire altre truppe da Livorno e da Pisa (rispettivamente due compagnie e uno squadrone di dragoni), ma la tensione tra militari e famigli non accennava a diminuire. Proprio per questo il sovrano volle che i processi fossero celebrati al più presto. Già la sera dell’11 maggio il tribunale degli Otto aveva così giudicato tutti i civili e gli sbirri arrestati, e quasi con la stessa rapidità agì il Consiglio di Guerra nei confronti dei militari coinvolti nei tumulti. Gli atti dell’inchiesta dimostrano chiaramente che gran parte della responsabilità era da attribuirsi agli ufficiali del reggimento dei granatieri. Alcuni di questi ufficiali, in particolare, furono accusati di aver istigato i loro soldati alla rivolta o comunque di non aver saputo mantenere la disciplina. Anche la massiccia partecipazione popolare risultava mossa esclusivamente dall’odio verso gli sbirri. L’analisi della composizione sociale degli arrestati conferma una larga partecipazione dei ceti popolari al tumulto: tra gli arrestati, o semplicemente giudicati a piede libero, troviamo sedici artigiani (cuoiai, calzolai, fornai, manovali, stampatori, sarti, tappezzieri, materassai, lanaioli, setaioli, ecc.), alcuni rappresentanti del settore commerciale (sensali, fruttaioli, ortolani, ecc.), dei servizi (garzoni, stallieri, vetturali, barbieri, infermieri) e perfino delle libere professioni (come il giovane di studio Michele Fares, il dottor Branchi, il dottor Leoni e il dottor Barchetti). È un campione sufficiente per rilevare che certamente non si trattò della protesta scaturita da un settore in crisi che avrebbe approfittato del conflitto tra militari e sbirri per manifestare il proprio malessere (come faranno invece i tessili pratesi nel 1787 inserendosi nella lotta contro il governo e la sua politica economica oltreché religiosa). Anche la giovane età di molti degli arrestati civili, provenienti dai ceti popolari fiorentini, sembra confermare l’ipotesi del tumulto spontaneo, favorito dalla generale insofferenza verso la politica moralizzatrice del sovrano e verso la «sbirraglia»; non si ebbero in altre parole né assalto ai forni né aggressioni a incettatori o mercanti di farine né qualsiasi altra manifestazione tipica dei tumulti annonari. Tanto più quindi i tumulti fiorentini spaventarono e preoccuparono le autorità che fecero pressione sul granduca perché punisse severamente tutti i sediziosi; e la punizione del sovrano non tardò a colpire con estrema severità tutti coloro che erano stati giudicati in qualche modo colpevoli e condannati. Nonostante che il granduca «per un atto della sua solita clemenza» abbia poi voluto «mitigare in parte a ciascheduno il gastigo che si era meritato», si procedette con rapidità all’esecuzione delle pene, avvenuta con lugubre solennità e pubblicamente nei giorni 16 e 17 maggio. Le esecuzioni, pur senza gli eccessi a cui erano stati sottoposti i condannati anche in un recente passato, mantennero tuttavia intatta quella teatralità, di cui ha parlato Michel Foucault, con cui doveva manifestarsi in tutto il suo splendore la forza invincibile del principe: la mattina del 16 maggio, una settimana dopo la conclusione dei tumulti, si eseguirono le condanne dei famigli e dei popolani. Per evitare ulteriori incidenti e per intimorire il popolo fu predisposto un servizio d’ordine costituito da alcuni picchetti di dragoni a cavallo al comando di altrettante guardie reali scelte, con il compito di pattugliare la città. I primi a subire le pene furono quattro famigli, condannati rispettivamente i primi due ad esser condotti «sopra una carretta con cartello alle spalle di ciascheduno esprimente – ai pubblici lavori – per eccessi commessi il di 9 maggio 1774» e gli altri due esiliati dal Granducato e condotti a piedi dietro detta carretta con cartello nelle spalle di ciascheduno esprimente «esiliato dal Granducato».

Dragoni toscani, da G. Conti, Firenze vecchia. Storia – cronaca aneddotica – costumi (1799-1859), Firenze, R. Bemporad & Figlio, 1899; ristampa anastastatica: Firenze, Giunti Marzocco, 1984
Il promotor fiscale Fallinucci fece pervenire al principe un rapporto immediato di queste esecuzioni: «Gli sbirri pazienti hanno preso in pace il gastigo, e il Fiori, che uccise il granatiere ha proferito dirimpetto a tutti gl’esecutori queste parole – io vado in galera per salvar tutti voi altri». Per il terrore sparso nel popolo da tale cerimoniale, il Fallinucci concludeva «che nulla è seguito di sinistro, né di tumulto, e ognuno pensa, trema, e tace». Seguirono poi al suono della campana le esecuzioni dei popolani arrestati a cominciare dai capi: Gaetano Lapucci che venne «frustato sull’asino con cartello in petto esprimente – per sussurratore» ed esiliato dal Granducato; un altro capo complotto, Michele Fares, ricevette la medesima condanna senza dover subire tuttavia l’onta della fustigazione. Subito dopo «si condussero fuori delle carceri ed alla porta del Palazzo degli Otto ventun soggetti giovanotti la maggior parte di 15 in 25 anni, tutti però della più infima plebe»; a cinque di questi «monelli» furono «servite» dodici nerbate ciascuno, ad eccezione di un ragazzo di 14 anni, al quale «se ne diedero sei solamente». Altri sedici tra gli arrestati furono obbligati ad assistere alle esecuzioni e poi vennero trattenuti ancora per qualche giorno alle Stinche. La mattina del 17, infine, si procedette alle esecuzioni dei dodici militari condannati, quasi tutti del corpo dei granatieri. Per primo toccò a Michele Giannetti, condannato ai pubblici lavori. Dopo il Giannetti fu la volta di due fucilieri che subirono nella piazza la loro condanna, «con aver passato l’un cinque e l’altro dieci volte per le bacchette in un filare di 300 uomini». Seguirono altri otto granatieri cui furono somministrate 60 bastonate ciascuno e per finire al granatiere Giovanni Baldi, altro capo complotto condannato all’esilio; dopo aver ricevute in piazza 60 bastonate fu degradato e rinchiuso nelle carceri degli Otto.
Questa «funzione», così come quella del giorno prima, entrambe durate «per più ore», fu seguita secondo le varie relazioni inviate al sovrano, da una grande quantità di gente. Pietro Leopoldo, che fin dalla mattina aveva chiesto all’Auditore Fiscale un esatto resoconto delle esecuzioni e dell’effetto che avevano «fatto nel pubblico», poteva ben essere soddisfatto. In effetti dopo quegli esempi Firenze non avrebbe più conosciuto episodi simili fino alle sollevazioni del 1790, scoppiate dopo la sua partenza per Vienna. La rapidità e la durezza della repressione ebbero evidentemente un effetto deterrente sulla popolazione, certo poco abituata a simili spettacoli.
Dopo quello di Firenze, tuttavia altri gravi tumulti si verificarono in alcuni centri del Granducato (Siena 1779, Grosseto 1782, Prato 1787) fino a quelli scoppiati un po’ ovunque nel 1790; sommosse talmente gravi che Pietro Leopoldo, da pochissimo trasferitosi a Vienna, decideva di ristabilire la pena di morte, per «tutti quelli i quali ardiranno di sollevare il popolo, o mettersi alla testa del medesimo per commettere eccessi o disordini». Così, se l’abolizione della pena di morte nel 1786 era stata il punto più alto della politica riformatrice in Toscana, il suo ripristino nel 1790 simboleggiava l’esplosione delle più interne contraddizioni che avevano contrassegnato tutto il venticinquennio di regno appena conclusosi.
Bibliografia di riferimento
- A. Wandruszka, Leopold II. Erzherzog von Osterreich Grossherzog von Toskana Konig von Ungarn und Bohmen Romischer Kaiser, 2 voll., Wien-Munchen, Herold, 1963-65 (trad. it. ridotta: Pietro Leopoldo. Un grande riformatore, Firenze, Vallecchi, 1968)
- G. Turi, Viva Maria. La reazione alle riforme leopoldine (1790-1799), Firenze, Olschki, 1969 (riedito nel 1999 da Il Mulino, con postfazione dell’autore sul tema delle insorgenze)
- M. Simondi, Classi povere e strategie del controllo sociale nel Granducato di Toscana (1765-1790), Firenze, Dipartimento statistico – Università degli studi di Firenze, 1983
- C. Mangio, La polizia toscana. Organizzazione e criteri d’intervento (1765-1808), Milano, Giuffrè, 1988
- F. Mineccia, I. Tognarini, Tumulti urbani nella Toscana di Pietro Leopoldo, in L. Berlinguer, F. Colao (a cura di), Criminalità e società in età moderna, Milano, Giuffrè, 1991, pp. 167-228
- B.M. Cecchini, L’“infame” Chelotti, bargello fiorentino. Abusi e prevaricazioni di un funzionario di polizia nella Toscana leopoldina (1772-1783), «Rassegna Storica Toscana», XXXVIII (1992), pp. 43-63
- S. Contini, La città regolata: polizia e amministrazione nella Firenze leopoldina (1777-1782), in Istituzioni e società in Toscana nell’età moderna, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, 1994, pp. 426-508 (Scarica pdf)
- A. Savelli, Per quiete della città: l’istituzione della truppa civica di Firenze l’11 aprile 1780, «Annali di Storia di Firenze», III (2008), pp. 245-298 (Scarica pdf)
Elenco dei link in ordine di citazione (il loro funzionamento è stato verificato nel marzo 2018)
- La Toscana al tempo di Pietro Leopoldo: bibliografia a cura della Biblioteca della Toscana “Pietro Leopoldo”
- Polizia: bibliografia sul Granducato di Toscana (dal website del Centro Interuniversitario di Studi “Le Polizie e il Controllo del Territorio”)
- Il fondo “Segreteria di Gabinetto” nel Sistema Informatico dell’Archivio di Stato di Firenze
- L’Archivio di Stato di Firenze nella Guida generale degli Archivi di Stato (pdf)
- La magistratura degli Otto di guardia e balìa nel Sistema Informatico dell’Archivio di Stato di Firenze
- Villa medicea del Poggio Imperiale
- L’Auditore Fiscale nel Sistema Guida generale degli Archivi di Stato italiani
Come citare questo articolo: Francesco Mineccia, Maggio 1774: tumulti a Firenze contro la polizia, in "Portale Storia di Firenze", Maggio 2018, https://www.storiadifirenze.org/?temadelmese=maggio-1774-tumulti-a-firenze-contro-la-polizia