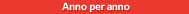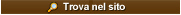Immagine di copertina:
Immagine di copertina:di Piero Gualtieri (Portale Storia di Firenze)
Immagine di copertina:
Luigi Baccio del Bianco?, La peste a Firenze nel 1630. Firenze, Museo della Misericordia (immagine tratta dal sito della mostra Arnolfo alle origini del Rinascimento; visibile nel tour virtuale www.misericordia.firenze.it/museo)

La peste, miniatura dal codice de Le Croniche di Giovanni Sercambi, seconda metà del XIV secolo, Archivio di Stato di Lucca
Yersinia pestis. Se si provasse oggi a chiedere per le strade di Firenze che cosa si nasconde dietro queste due parole dal suono forse un po’ esotico sarebbero quasi sicuramente molto pochi, per non dire pochissimi, quelli capaci di rispondere correttamente.
Se una simile domanda fosse stato rivolta ai fiorentini del 1348 nessuno, e questa volta ne siamo pienamente certi, sarebbe stato in grado di rispondere. Eppure, proprio quei nostri antenati di più di settecentocinquanta anni fa avrebbero avuto tutto l’interesse a conoscere quella risposta che nel giro di pochi mesi tanti, tantissimi – in una percentuale che varia dalla metà ai due terzi del totale degli abitanti della città, secondo le diverse stime – avrebbero tragicamente scoperto a proprie spese. Lo Yersinia pestis non è infatti altro che un semplice batterio – un cocco-bacillo, per la precisione –, responsabile di una delle malattie più letali, capace di originare alcune fra le peggiori pandemie che l’Europa (e il mondo intero) abbia conosciuto: la peste bubbonica, nota anche come “peste nera”.
D’altra parte, le nostre conoscenze sull’origine e prima diffusione di questa malattia sono state relativamente scarse fino a poco tempo fa, e solo in questi ultimi anni sono state compiute alcune scoperte che hanno permesso di svelarne aspetti poco noti o del tutto sconosciuti. Nel 2011, infatti, è stata completata la mappatura del genoma del nostro batterio, che ha permesso ad esempio di individuarne con certezza la derivazione da un batterio del terreno. Sul piano più propriamente storico della diffusione e incidenza della malattia permangono invece numerosi punti oscuri.
Uno degli aspetti maggiormente controversi è senza dubbio quello relativo all’identificazione stessa della malattia: gli antichi tendevano infatti a qualificare genericamente come ‘peste’ morbi e affezioni che oggi sappiamo essere generati da agenti patogeni differenti (come ad esempio il batterio del tifo). L’epidemia più famosa di peste nera è in ogni caso senz’altro quella che attraversò tutta l’Europa fra il 1348 e il 1350, per poi ricomparire, in maniera meno grave, per varie volte nei decenni successivi. Seguiamone brevemente il percorso fino alle porte di Firenze.
La “Grande moria”, la “Morte Nera”, come a volte è indicata nelle fonti, si sviluppò con certezza nel grande ventre del continente asiatico: secondo le ultime ricerche la probabile culla sarebbe stata una zona dell’attuale Mongolia. Da lì, il morbo avrebbe viaggiato, percorrendo le vie carovaniere e la “via della seta” per giungere a Samarcanda, e da qui spargersi per tutto il Medio Oriente. La cronologia dei diversi spostamenti non è del tutto certa: sicuramente, tuttavia, esso infuriava a Caffa, sulle rive del Mar Nero, nel corso del 1346. Una galea genovese proveniente da questa città approdò a Messina nell’estate del 1347, diffondendovi l’infezione. Sbarcata in Sicilia, la peste si diffuse per tutta l’isola, e da qui sul continente – Genova e Venezia furono le prime città ad essere colpite. Nel mese di marzo del 1348, con ogni probabilità (secondo quanto riportato dai cronisti Matteo Villani e Marchionne di Coppo Stefani l’impennata vera e propria della mortalità si ebbe con l’inizio di aprile), essa fece infine le prime vittime anche a Firenze.
Giunti ormai dentro le mura della città, soffermiamoci ad analizzare quali furono le modalità di diffusione del contagio e il decorso della malattia. L’ipotesi maggiormente accreditata è quella che vede coinvolti pulci e ratti: sarebbero state le prime, cibandosi del sangue degli animali infetti, a trasmettere il batterio a nuovi ratti sani e soprattutto agli uomini, alimentando in tal modo la diffusione del morbo. La rapidità e la pervasività del contagio ha spinto alcuni studiosi ad avanzare l’ipotesi dell’esistenza di una qualche forma di trasmissione da uomo a uomo (come per la peste polmonare, anch’essa causata dallo Yersinia), ma la teoria della trasmissione attraverso le pulci e i ratti – viste anche le tante testimonianze del tempo sulla presenza dei bubboni sui corpi degli ammalati – rimane quella più accreditata. Dopo essere stata infettata, infatti, la persona ammalata si trovava ben presto a fare i conti con una serie di sintomi, il più appariscente dei quali era senza dubbio la comparsa di rigonfiamenti, o “bubboni”, in determinate zone del corpo.
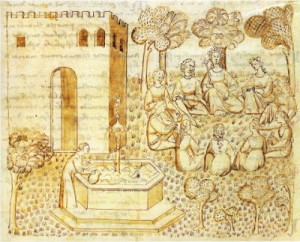
La Brigata del Decameron, disegno a penna (autografo del Boccaccio?) dal codice Parigino italiano 482. Parigi, Bibliothèque Nationale
Per descrivere le varie fasi dell’insorgenza della malattia, in ogni caso, non vi sono parole migliori di quelle celebri che Giovanni Boccaccio pose all’inizio della Prima Giornata del suo Decameron: nascevano nel cominciamento d’essa a’ maschi e alle femine parimente o nella anguinaia o sotto le ditella certe enfiature, delle quali alcune crescevano come una comunal mela, altre come uno uovo, e alcune più e alcun’ altre meno, le quali i volgari nominavan gavoccioli. E dalle due parti del corpo predette infra brieve spazio cominciò il già detto gavocciolo mortifero indifferentemente in ogni parte di quello a nascere e a venire: e da questo appresso s’incominciò la qualità della predetta infermità a permutare in macchie nere o livide, le quali nelle braccia e per le cosce e in ciascuna altra parte del corpo apparivano a molti, a cui grandi e rade e a cui minute e spesse. E come il gavocciolo primieramente era stato e ancora era certissimo indizio di futura morte, così erano queste a ciascuno a cui venieno.
La scienza odierna, oltre a confermare nello specifico il quadro dipinto dal Boccaccio, ci dice in aggiunta che, ieri come oggi, la malattia si manifestava con estrema virulenza dopo un periodo di incubazione compreso fra 2 e 10 giorni, con l’insorgere di una febbre violenta, associata variamente a brividi e forte malessere, cefalea, dolori muscolari, vomito, obnubilamento e delirio. Se non curati in maniera rapida ed adeguata, i malati di peste bubbonica morivano (e muoiono) in genere entro una settimana, per collasso cardiovascolare provocato dal peggioramento dell’infezione.
Anche solo dalla semplice lettura dei sintomi è facile comprendere come i fiorentini del 1348 (che per di più venivano da alcuni anni di grave carestia, che aveva fortemente provato larghi strati della popolazione) fossero del tutto impotenti a contrastare la diffusione del morbo. Le condizioni di vita generale, soprattutto per quanto riguardava l’igiene delle persone e degli ambienti, rendevano del tutto impossibile l’applicazione di una qualche forma di profilassi contro il contagio – specie in una vera e propria metropoli come era la Firenze del tempo. Il Boccaccio annota in questo senso come non solamente il parlare e l’usare cogli infermi dava a’ sani infermità o cagione di comune morte, ma ancora il toccare i panni o qualunque altra cosa da quegli infermi stata tocca o adoperata pareva seco quella cotale infermità nel toccator transportare.
La pratica medica era del resto fondata sulla teoria dei quattro umori sistematizzata da Galeno, e identificava quale causa della peste una sorta di corruzione dell’aria che avrebbe causato direttamente la formazione di una sorta di veleno all’interno del corpo dell’uomo. Accanto a tale spiegazione (e ad altre che chiamavano in causa anche gli influssi degli astri), vi era poi radicata la convinzione che la pestilenza fosse una punizione inviata da Dio per punire i peccati commessi dagli uomini. Da qui, come ci raccontano ancora Boccaccio e i cronisti del tempo, il ricorso a una serie infinita di rimedi, che spaziava dall’uso di erbe o aceto (da portare a contatto del viso anche grazie all’aiuto di speciali maschere) contro i miasmi, all’adozione di speciali regimi alimentari, al ricorso a frequenti salassi, alla proibizione dei rapporti sessuali.

Buonamico Buffalmacco, Particolare dal Trionfo della morte, 1330 circa. Pisa, Camposanto Monumentale
Dopo aver fatto le prime vittime in marzo ed essere esplosa il mese successivo, a Firenze la peste imperversò così indisturbata per tutta l’estate fino in pratica alla fine di settembre di quello stesso 1348, quando la virulenza del contagio cominciò infine a scemare gradatamente (perché il pericolo potesse dirsi scampato fu tuttavia necessario attendere l’autunno successivo). Nella fase di maggiore intensità della moria, per dare sepoltura alle centinaia di cadaveri che si accumulavano fra le case e le strade, aumentando fra le altre cose il rischio di contagio, si ricorse a grandi fosse comuni, dove, come ci racconta lo Stefani, i corpi erano gettati alla rinfusa in grandi strati divisi da un velo di terra, come si ministrasse lasagne a fornire di formaggio.
Come detto, per Firenze (ma le percentuali sono più o meno le stesse per tutta l’Europa) le stime sul numero delle vittime oscillano dalla metà ai due terzi del totale degli abitanti: dando per molto probabile la presenza in città di poco più di 100.000 abitanti alla vigilia dell’arrivo del morbo il totale delle vittime dovrebbe collocarsi intorno alle 60.000 unità. Numeri che, come si suol dire, parlano da soli, e che aiutano in qualche modo a comprendere lo sconvolgimento a cui andò in contro la società fiorentina, che ne uscì profondamente trasformata.
La vita civile fu sconvolta: fra agosto e settembre il governo cittadino emanò una nutrita serie di provvedimenti volti ad ovviare in qualche modo alla paralisi che si era originata a motivo della moria. I rapporti umani vennero stravolti; ancora Boccaccio: lasciamo stare che l’uno cittadino l’altro schifasse e quasi niuno vicino avesse dell’altro cura e i parenti insieme rade volte o non mai si visitassero e di lontano: era con sì fatto spavento questa tribulazione entrata ne’ petti degli uomini e delle donne, che l’un fratello l’altro abbandonava e il zio il nipote e la sorella il fratello e spesse volte la donna il suo marito; e (che maggior cosa è e quasi non credibile), li padri e le madri i figliuoli, quasi loro non fossero, di visitare e di servire schifavano. E certo dovettero essere numerose le famiglie uscite stremate, se non annientate del tutto, dal passaggio della ‘Grande moria’.
Perfino la struttura materiale della città ne uscì durevolmente compromessa. Nel giro di pochi mesi numerose abitazioni furono abbandonate a causa della morte dei loro occupanti. La nuova cerchia di mura completata da pochi anni (anche se già sproporzionata in partenza) rimase come una sorta di cintura troppo larga per la città, con campi e spazi di verde che non furono occupati dalle costruzioni fino al pieno XIX secolo.
Certo, in mezzo a tanti disagi, vi furono molto probabilmente anche alcune conseguenze positive, almeno per gli strati meno abbienti della popolazione. Sembra infatti – ma fra gli storici non vi è accordo unanime su questo punto – che a causa della penuria di uomini i vari salariati cittadini impegnati nell’industria tessile (come anche i mezzadri del contado) riuscirono per un certo periodo a strappare migliori condizioni di lavoro.
Al di là delle possibili considerazioni sull’andamento dei prezzi e dei salari, in ogni caso, quello che certo accomunò i sopravvissuti, ricchi e meno ricchi, fu senz’altro la consapevolezza di essere scampati a un flagello epocale.
Elenco dei link in ordine di citazione (il loro funzionamento è stato verificato il 7 marzo 2013):
- Sul cocco-bacillo
- Sulla peste
- Articolo della rivista “Nature” relativo alla mappatura del genoma
- Sul tifo
- Note biografiche su Giovanni Boccaccio
- Testo integrale del Decameron
- Significato del termine ‘profilassi’
- Note sintetiche sulla teoria dei quattro umori
- Note biografiche su Galeno
Bibliografia essenziale
La peste nera: dati di una realtà ed elementi di una interpretazione, Spoleto, Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, 1994.
Morire di peste. Testimonianze antiche e interpretazioni moderne della peste nera del 1348, a cura di O. Capitani, Bologna, Pàtron, 1995.